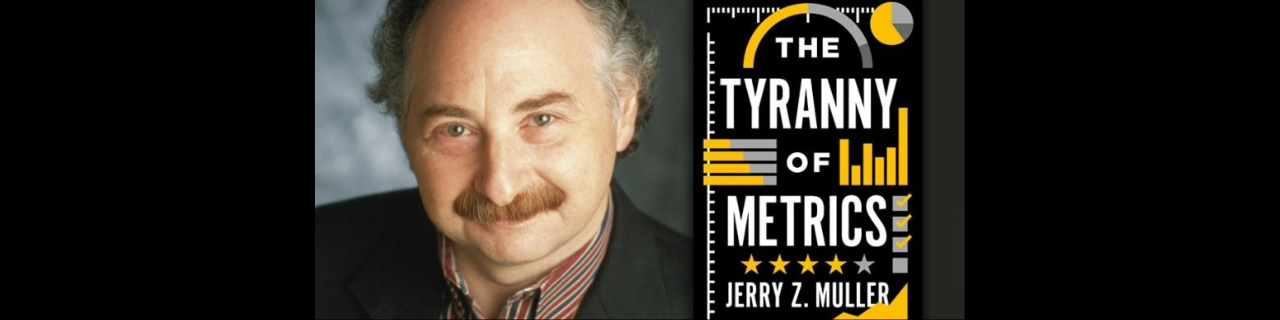
È il titolo di un saggio di Jerry Z. Muller, pubblicato nel 2019 dalla LUISS university press, la cui lettura è raccomandabile a tutti, non soltanto agli economisti. Il titolo originale ‘la tirannia della metrica’, rispecchia meglio la tesi dell’Autore, che non è affatto contro la matematica, ma contro l’uso dilagante di paradigmi matematici per valutare aspetti fondamentali dell’agire e del sentire umano che non sono quantificabili.
Negli ultimi anni, dice l’Autore, l’ossessione per i parametri ha toccato tutte le sfere dell’agire umano, incluse le istituzioni educative, politiche e sociali, non soltanto il mondo aziendale. Tale ossessione nasce dalla convinzione che soltanto ciò che si può contare riesce davvero a responsabilizzare le istituzioni, anche se è evidente che nella realtà non tutto ciò che è importante è misurabile e gran parte di ciò che è importante non è misurabile. E poiché tutte le istituzioni hanno molteplici obbiettivi, è facile focalizzarsi su quelli che possono essere misurati a scapito di altri ben più importanti, anche se non facilmente misurabili. Obbligare le persone a lavorare per raggiungere obbiettivi numerici prestabiliti tende a reprimere l’innovazione e la creatività e a dare più importanza agli obbiettivi di breve periodo che a quelli di lungo periodo. Inoltre spinge molti a manipolare i parametri di performance per ottenere premi o altri vantaggi.
Fu nel lontano1862 che il deputato liberale britannico Robert Lowe propose un nuovo metodo per gestire i finanziamenti pubblici alle scuole, basato sulla quantificazione dei risultati, cioè sul numero di studenti che le scuole mettevano in grado di leggere, scrivere e far di conto. Il piano fu contrastato dal celebre critico letterario Matthew Arnold, impiegato come ispettore governativo proprio nelle scuole sotto la giurisdizione di Lowe. Con grande coraggio Arnold si scagliò contro il suo superiore nel celebre saggio ‘ The twice revised code’ (la doppia riforma del codice). La capacità di leggere con intelligenza, scrisse Arnold, non si sviluppa attraverso lezioni concepite per imparare a leggere, ma da una formazione generale acquisita in famiglia, o in ambiente scolastico capace di infondere il desiderio di leggere. Arnold prevedeva che il solo risultato della riforma sarebbe stato la riduzione dei finanziamenti alle scuole per i meno abbienti. Questa concezione meccanica dell’istruzione, concepita come una serie di ingranaggi costruiti appositamente per produrre risultati misurabili e poter così raggiungere obbiettivi numerici indicati dai finanziatori e/o dai legislatori, non è mai stata superata. Nel corso del 1900 in tutto il mondo occidentale sono state lanciate politiche scolastiche volte a raggiungere risultati quantificabili secondo diversi parametri, tutti numerici, nella convinzione che, come nella produzione in serie, la massima efficienza dell’educazione si sarebbe potuta raggiungere attraverso la standardizzazione del processo educativo. Una delle conseguenze è l’abbassamento costante degli standard per permettere ad un numero sempre maggiore di studenti di raggiugere gli obbiettivi quantificabili. Ma proprio le statistiche mostrano che il divario fra gli studenti provenienti da gruppi etnoculturali e sociali diversi non è cambiato: anche oggi gli studenti riescono meglio a scuola e nel lavoro se provengono da alcuni gruppi etnoculturali, esattamente come un secolo fa. La scolarizzazione di massa secondo parametri misurabili non ha ridotto il divario sociale, perché non ha inciso a fondo sulla capacità di comprensione, valutazione e giudizio.
Anche nel settore della difesa i risultati della valutazione numerica sono stati provati negativi dall’esperienza. Quando Mac Namara divenne segretario alla difesa (dal 1961 al 1968) e dovette affrontare la guerra in Vietnam, promosse l’uso della ‘conta dei morti’, presumendo fosse l’indice più affidabile per valutare i progressi degli americani nella guerra in corso – e la guerra fu persa, anche se i nemici persero molti più uomini. Perché l’unica vera misura dei progressi in guerra non è quantificabile: è l’impatto sulla volontà del nemico di continuare a combattere. Luttwak criticò aspramente il metodo ‘contafagioli’ di Macnamara e definì ‘preconcetto materialista’ la tendenza a misurare le risorse anziché i fattori umani immateriali come la strategia, la capacità di comando, la coesione del gruppo e il morale delle truppe.
‘La domanda di parametri di accountability (rendicontazione) e di trasparenza aumenta al diminuire della fiducia’ scrive Muller. Con l’aumento dell’eterogeneità etnica e culturale aumenta la sfiducia fra i gruppi e il timore di essere trattati e valutati ingiustamente. I numeri trasmettono una sensazione di oggettività e comportano l’esclusione del giudizio soggettivo – di cui non ci si fida più. Allora si costruiscono parametri su parametri, impostati sorvegliati e gestiti da burocrazie sempre più ampie e complesse - senza nessuna certezza di un miglioramento effettivo della realtà. Già negli anni ’80 nelle università americane il personale amministrativo era diventato più numeroso del personale docente, e da allora la sproporzione è aumentata. I numeri sostituiscono la fiducia nel giudizio soggettivo e basato sull’esperienza di chi è al potere. In un circolo vizioso, la mancanza di fiducia sociale porta all’apoteosi dei parametri e la fede nei parametri alimenta la sfiducia nel giudizio personale. Il giudizio umano è considerato troppo pericoloso. Il risultato è un eccesso di regolamentazione, una fitta rete di vincoli e una selva di normative interne alle organizzazioni.
Quindi si moltiplicano i contenziosi, i soldi spesi in avvocati, le incriminazioni per questioni amministrative.
La fede nei numeri nasce dalla convinzione che, dato il necessario corredo di dati informativi, qualunque persona può prendere le ‘giuste’ decisioni in materia di sanità, istruzione, politica pensionistica, politica di difesa, perché ogni persona è dotata di razionalità. Così si svalutano l’esperienza, la capacità di giudizio, nonché la lealtà verso il gruppo, la cooperazione creativa, il coraggio di assumersi rischi tipico degli imprenditori, dei leader e degli innovatori. Si cerca invece la perfetta trasparenza di ogni situazione attraverso cumuli di dati. I burocrati oggi stabiliscono obbiettivi quantitativi per la performance di scuole, ospedali, forze di polizia, proprio come i governi del blocco sovietico fissavano gli obbiettivi di produzione delle fabbriche.
Ci sono poi campi in cui la ‘trasparenza’ dei dati è impossibile o negativa dice Muller: la politica, la diplomazia, i servizi segreti e il matrimonio. Così come ogni relazione intima. La nostra identità si realizza solo perché i nostri pensieri e i nostri desideri non vengono mostrati agli altri. Possiamo stringere relazioni intime solo se riusciamo ad essere più trasparenti con alcune persone e meno con altre (…) Se i pensieri di una persona fossero scritti sulla sua fronte e tutti potessero vederli, svanirebbe la distinzione fra esterno e interno e con essa l’individualità. La sfera privata, che è il luogo dove si nascondono le cose, consente alla persona di affermarsi come individuo. Pare un altro ottimo spunto per una lunga riflessione anche sulle politiche ‘identitarie’.
I vostri commenti
Per questo articolo non sono presenti commenti.
Lascia un commento
Vuoi partecipare attivamente alla crescita del sito commentando gli articoli e interagendo con gli utenti e con gli autori?
Non devi fare altro che accedere e lasciare il tuo segno.
Ti aspettiamo!
Accedi
Non sei ancora registrato?
Registrati